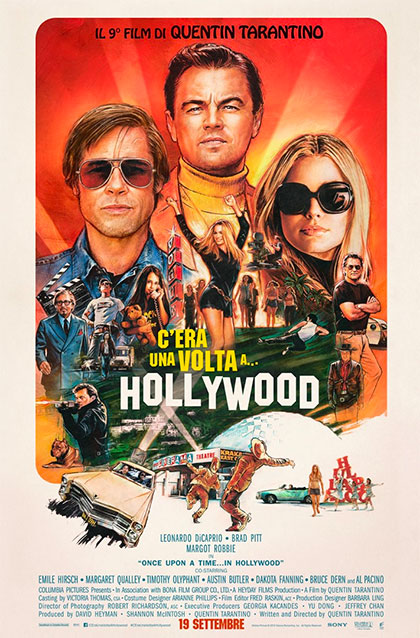“C’erano sei trilioni di alberi nel mondo,
quando gli uomini hanno fatto capolino la prima volta. Metà è rimasta. Un’altra
metà scomparirà nel giro di un centinaio d’anni”
Il
Premio Pulitzer 2019 “Il sussurro del
mondo” (La nave di Teseo) di Richard Powers è approdato nelle nostre
librerie carico di presagi, vibrazioni e attese, romanzo la cui lettura
dovrebbe essere preceduta o accompagnata dalla visita dei grandi parchi californiani
fittamente costellati di sequoie.
Non è
facile incunearsi fra i cunicoli ombrosi e umidi di un lavoro complesso, impegnativo,
articolato, gravido di idee, pensieri, ampollosi ghirigori linguistici,
spiritualità e panteismo. La sua lettura è feconda quanto defatigante.
“Tagone ha detto, Gli alberi rappresentano l’infinito
sforzo umano di parlare con i cieli in ascolto”.
Lo
stile barocco e salmodiante è assediato da turbinii di parole che rischiano di opprimere
la fluidità del racconto, rimanendo talora schiacciato da esse come una casupola
da un baobab. Le parole stormiscono inebriando o stordendo il lettore. La narrazione
è offuscata dalla lunghezza che può apparire eccessiva storpiando l’incisività
narrativa: un alto voltaggio che invece di esplodere su un mozzicone di filo di
rame si sbrodola su estensioni troppo vaste. Visioni allucinatorie e oniriche,
ambientazioni surreali e richiami biblici sono percorsi da un linguaggio
ricercato sino al più puntuto tecnicismo terminologico. L’Autore sembra quasi
perdersi nella parola, ingarbugliandosi come dentro una rete da pesca. La
storia si immerge in una nebbia che si infittisce nell’incedere della trama,
per poi apparire nuovamente in una valle rischiarata dalla luce fioca dell’imbrunire
e divenire dopo più intensa, il giorno successivo, nell’ affacciarsi del
mezzodì. La scrittura si fa affabulazione botanica avvolta in un grumo di
antropomorfismo vegetale e di illusioni pareidolitiche. L’ambiente è l’alfa e l’omega
e l’uomo ne è solo un segmento, ma non il più importante, il retroscena, il
proscenio, il palcoscenico, il sottofondo e la colonna sonora, un frusciar di
foglie, un batter d’ali, carnefice e vittima di se stesso. La storia sembra
fuori dal tempo e il lettore viene riacciuffato da Kronos solo grazie a fugaci richiami all’11 settembre e alla
protesta di Occupy Wall Street. Dalla
canopia l’Autore guarda in direzione della memoria di cui gli alberi sono
antichi coreuti, mentre volge lo sguardo verso un futuro sradicato dall’Umanità.
Powers è agli antipodi di
Kant: l’uomo non è fine a se stesso ma dentro una dimensione visibile e invisibile
in seno alla quale opera, spesso, troppo spesso, come agente patogeno.
Le
ideologie imprigionano le menti; le galere imprigionano i corpi; le invalidità
imprigionano le muscolature che, disperate, sprigionano la loro energia attraverso
la mente che costruisce nuovi mondi e nuove nature, esistenti solo nella
dimensione immaginifica del web.
L’olocausto
delle piante: “La vita si surriscalderà,
i mari si alzeranno di livello. I polmoni del pianeta verranno strappati. E la
legge permetterà che succeda, perché il torto non è mai stato abbastanza
imminente. Imminente, alla velocità delle persone, è troppo tardi. Imminente va
giudicato dalla legge alla velocità degli alberi”.
La
solitudine degli uomini e in antinomia con l’armonia delle piante. Gli alberi
sono esseri viventi e le foreste comunità che si scambiano doni materiali e
immateriali al suo interno e con il resto del Mondo. L’albero è Xenia e deve essere curato ma, prima ancora, v’è la
necessità primigenia di guarire l’essere umano.
“Fuori, nel putridume, nella decomposizione,
i ceppi, la morte lussureggiante e prolifica intorno a loro, dove cresce un
terribile verde, che si spande in tutte le direzioni con le sue spirali mutanti”.
Fabrizio Giulimondi